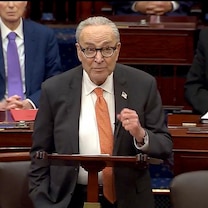La Francia piange i gioielli della corona rubati mentre il suo scomodo passato coloniale torna alla luce

PARIGI -- Mentre la polizia francese si affretta a scoprire dove siano finiti i gioielli della corona rubati al Louvre , un coro sempre più numeroso chiede di fare luce sulla loro provenienza.
I manufatti erano francesi, ma le gemme no. Le loro esotiche rotte verso Parigi attraversano le ombre dell'impero: una storia scomoda che la Francia, come altre nazioni occidentali con musei pieni di tesori, ha appena iniziato ad affrontare.
L'attenzione suscitata dal furto è un'opportunità, affermano gli esperti, per fare pressione sul Louvre e sui grandi musei europei affinché spieghino in modo più onesto le origini delle loro collezioni, e potrebbe innescare una più ampia valutazione delle restituzioni.
Nel giro di poche ore dal furto, i ricercatori hanno tracciato una probabile mappa dell'era coloniale dei materiali: zaffiri da Ceylon (Sri Lanka), diamanti dall'India e dal Brasile, perle dal Golfo Persico e dall'Oceano Indiano e smeraldi dalla Colombia.
Ciò non rende il furto al Louvre meno criminale. Di certo complica la comprensione da parte del pubblico di ciò che è andato perduto.
"Ovviamente non ci sono scuse per il furto", ha affermato Emiline CH Smith, criminologa dell'Università di Glasgow che studia i reati contro il patrimonio culturale. "Ma molti di questi oggetti sono legati a storie coloniali violente e di sfruttamento".
Sebbene non ci siano prove attendibili che queste gemme specifiche siano state rubate, gli esperti affermano che questo non pone fine alla discussione: ciò che era legale in epoca imperiale potrebbe ancora essere considerato un saccheggio ai giorni nostri. In altre parole, la burocrazia dell'impero non determina l'etica.
Nel frattempo, le indagini sulla rapina proseguono. La polizia ha incriminato i sospettati, ma gli investigatori temono che i gioielli possano essere rotti o fusi. Sono troppo simbolici per essere venduti, ma facili da monetizzare grazie al metallo e alle pietre.
Il Louvre fornisce scarse informazioni sulle modalità con cui vennero originariamente estratte le gemme dai gioielli della corona francese, esposti nella Galleria Apollo fino al furto.
Ad esempio, il catalogo del Louvre descrive il diadema rubato della regina Maria Amelia come incastonato con "zaffiri di Ceylon" allo stato naturale, non riscaldati, bordati di diamanti in oro. Non dice nulla su chi li abbia estratti, come siano stati trasportati o in quali condizioni siano stati rubati.
La provenienza non è sempre un dato neutrale nei musei occidentali. A volte "evitano di mettere in luce storie di acquisizioni scomode", ha detto Smith, aggiungendo che la mancanza di chiarezza sulle origini delle gemme non è probabilmente casuale.
Il museo non ha risposto alle richieste di commento.
Le tiare, le collane e le spille rubate furono realizzate a Parigi da atelier d'élite e un tempo appartenevano a personaggi del XIX secolo come Maria Amelia, la regina Ortensia e le mogli di due Napoleoni, l'imperatrice Maria Luisa d'Austria e l'imperatrice Eugenia. Le loro materie prime, tuttavia, transitavano attraverso reti imperiali che convertivano manodopera, risorse globali – e persino la schiavitù – in prestigio europeo, affermano gli esperti.
Pascal Blanchard, storico del passato coloniale francese, traccia una linea di demarcazione tra artigianato e produzione. I gioielli "erano realizzati in Francia da artigiani francesi", ha affermato, ma molte pietre provenivano dai circuiti coloniali ed erano "prodotti della produzione coloniale". Venivano scambiati "secondo le condizioni legali... dell'epoca", plasmate da imperi che sottraevano ricchezza all'Africa, all'Asia e al Sud America.
Alcuni critici francesi insistono ulteriormente su questo punto. Sostengono che il clamore nazionale per la perdita dovrebbe essere messo in relazione con la storia di come la Francia imperiale acquisì le pietre che i gioiellieri di corte incastonarono poi nell'oro.
L'India sta combattendo la battaglia più nota per un singolo tesoro dell'era coloniale: il diamante Koh-i-Noor.
L'India ha ripetutamente fatto pressione sul Regno Unito affinché restituisse il mitologico gioiello da 106 carati, ora incastonato nella corona della Regina Madre nella Torre di Londra. Probabilmente proveniva dalla cintura di diamanti indiana di Golconda, proprio come lo splendido diamante Regent del Louvre, anch'esso acquisito legalmente in epoca imperiale e risparmiato dai ladri del 19 ottobre.
Il Koh-i-Noor passò di corte in corte prima di approdare in mani britanniche, dove venne accolto a Londra come un dono imperiale "legittimo" e denunciato in India come una preda sottratta all'ombra della conquista. Una petizione del 2017 alla Corte Suprema indiana che ne chiedeva la restituzione fu respinta per motivi di giurisdizione, ma la controversia politica e morale perdura.
La Francia non è la Gran Bretagna, e il Koh-i-Noor non è la storia del Louvre. Ma inquadra le domande sempre più ricorrenti nelle acquisizioni del XIX secolo: non solo "è stato acquistato?", ma "chi aveva il potere di venderlo?". In base a questo criterio, affermano gli esperti, anche i gioielli realizzati in Francia possono essere considerati prodotti di estrazione coloniale.
Il caso del Louvre si inserisce in un mondo già preda di altre battaglie. La Grecia fa pressione sulla Gran Bretagna affinché riunisca i marmi del Partenone. L'Egitto rivendica la Stele di Rosetta a Londra e il busto di Nefertiti a Berlino.
La Francia si è mossa, ma di poco. L'impegno del presidente Emmanuel Macron di restituire parte del patrimonio africano ha prodotto una legge che consente la restituzione di 26 tesori reali al Benin e di oggetti al Senegal. Il Madagascar ha recuperato la corona della regina Ranavalona III attraverso una procedura specifica.
I critici affermano che la restituzione è strutturalmente bloccata: la legge francese proibisce la rimozione degli oggetti di proprietà dello Stato, a meno che il Parlamento non faccia un'eccezione speciale, e i musei avversi al rischio tengono il resto dietro vetro.
Sostengono inoltre che, sotto la direzione dell'ex direttore del Louvre Jean-Luc Martinez, la definizione restrittiva di ciò che si intende per "saccheggiato" da parte del museo – e la sua richiesta di prove di livello quasi legale – abbia creato un effetto paralizzante sulle richieste di restituzione, nonostante il museo ne abbia pubblicamente elogiato la trasparenza. (Il Louvre afferma di rispettare la legge e gli standard accademici.)
Chiedere ai visitatori di un museo di ammirare manufatti come i gioielli della corona francese senza comprenderne la storia sociale è disonesto, afferma Erin L. Thompson, studiosa di crimini d'arte di New York. Un approccio decolonizzato, sostengono lei e altri, indicherebbe la provenienza di tali pietre, come funzionava il commercio, chi ne traeva profitto e chi pagava, e condividerebbe la paternità con le comunità di origine.
L'archeologa egiziana Monica Hanna definisce la contraddizione lampante.
"Sì, l'ironia è profonda", ha detto a proposito del clamore suscitato dal furto al Louvre del mese scorso, "ed è centrale nel dibattito sulla restituzione". Si aspetta che il furto innescherà azioni sulle restituzioni nei musei occidentali e alimenterà il dibattito sulla trasparenza.
Come minimo, affermano Hanna e altri esperti, ciò di cui i musei hanno bisogno sono parole più incisive: etichette chiare e testi murali che indichino la provenienza degli oggetti, come sono stati spostati e a spese di chi. Significherebbe pubblicare ciò che è noto, ammettere ciò che non lo è e accogliere storie controverse nelle gallerie, anche quando ne offuscano la bellezza.
Alcuni propongono un percorso pratico.
"Raccontate la storia onesta e completa", ha detto lo specialista olandese in restituzioni Jos van Beurden. "Aprite le finestre, non per far entrare i ladri, ma per far entrare aria fresca".
___
La giornalista dell'Associated Press Danica Kirka di Londra ha contribuito a questo rapporto
ABC News